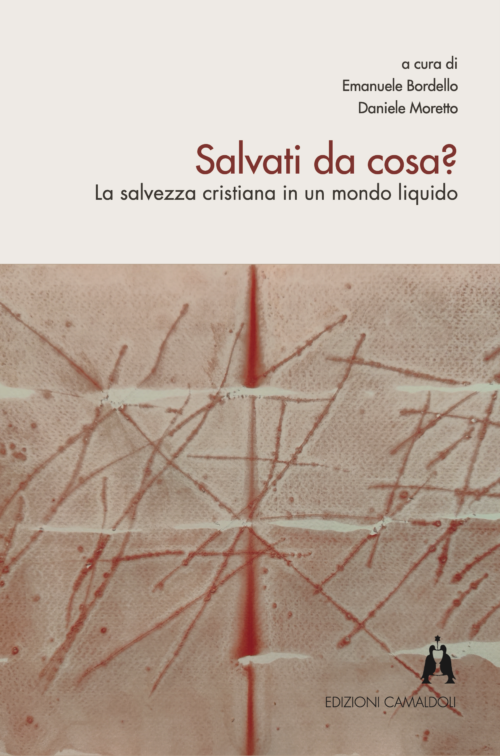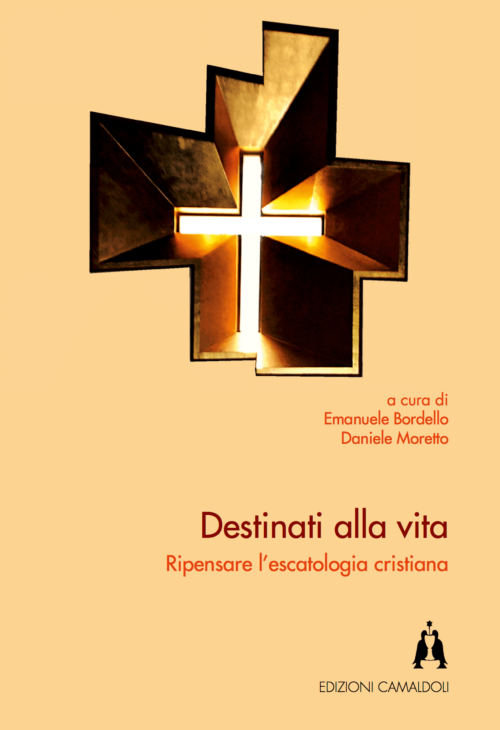Descrizione
Rapporto tra Homo Sapiens e Homo Religiosus
a cura di Roberto Tagliaferri
Quattromila anni fa gli uomini sono riusciti a creare una teoria della complessità attraverso il mito creazionista, molto più articolato delle risposte che abbiamo oggi dalla scienza. Si potrebbe dire che l’Homo Sapiens è riuscito a produrre la complessità dentro una metafora come quella della creazione.
Il creazionismo non è altro che l’idea teleologica del mondo: c’è stato un inizio, ci sarà una fine e tutte le cose si muovono verso la fine, o come diceva Eraclito, «la nascita ha in sé la sua morte», il suo compimento. Noi abbiamo tradotto l’aforisma con «la natura ama nascondersi», dando inizio alla ricerca scientifica per strappare i segreti della natura, ma l’adagio antico aveva tutt’altro significato, come ci spiega il filosofo Pierre Hadot nel saggio Il velo di Iside: la scoperta di ciò che ci sfugge all’origine di ogni ricerca umana, ieri come oggi.
Dovremmo essere molto più interessati a stabilire come l’uomo sia riuscito a creare letteratura, credenze, musica, canti, danze, immagini, monumenti, tecnologie e quant’altro, per questa sua capacità di creare mondi possibili e di modificare ambienti. Proprio questa capacità sorregge la domanda sul rapporto tra “Homo sapiens” e “Homo religiosus”, che è il sottotitolo del convegno “Evoluzionismo antropologico” svoltosi a Camaldoli qualche anno fa, di cui il presente volume riporta i contributi dei singoli relatori – Tagliaferri, Pievani, Terrin – e il dibattito molto vivo che ne è sorto sullo specifico della evoluzione antropologica rispetto alla teoria darwiniana della evoluzione biologica.